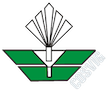Le due aree geotermiche toscane, dove sono ubicate le centrali geotermiche italiane, sono caratterizzate da alcuni elementi tipici delle aree rurali e periferiche: bassa densità di popolazione, piccoli borghi, deboli infrastrutture (strade, telecomunicazioni, ecc.).
Il tessuto produttivo manifatturiero, nato principalmente all’ombra di ENEL, è costituito in buona misura da piccole o micro imprese che soffrono dei sintomi tipici delle economie “monocolturali” e fanno fatica a diversificare il loro business.
La mescolanza di tali fattori si traduce in scenari di sviluppo ad alto rischio di marginalizzazione socioeconomica, spopolamento e disoccupazione.
Scenari che, peraltro, le amministrazioni locali e gli operatori economici tentano costantemente di arginare.
 Al fine di promuovere lo sviluppo socio-economico locale nel 1988 nasce CoSviG, il Consorzio per lo Sviluppo di Aree Geotermiche, con l’obiettivo di coordinare gli sforzi delle autorità locali per innescare la nascita di nuove iniziative socio-economiche.
Al fine di promuovere lo sviluppo socio-economico locale nel 1988 nasce CoSviG, il Consorzio per lo Sviluppo di Aree Geotermiche, con l’obiettivo di coordinare gli sforzi delle autorità locali per innescare la nascita di nuove iniziative socio-economiche. Il ruolo istituzionale a servizio delle aree geotermiche è cresciuto e si è poi consolidato quando – nel 2007 – con i comuni geotermici, la Regione Toscana ed Enel è stato firmato l’Accordo Generale sulla geotermia tra i comuni geotermici, la Regione Toscana ed Enel e, l’anno successivo, il collegato Accordo di Programma.
Obiettivo era quello di proporre un modello di sviluppo locale integrato e sostenibile, in linea con le vocazioni economiche e le tradizioni locali di questi territori.
Da questi Accordi sono derivati – e derivano tuttora – una serie di benefici per le comunità locali grazie agli impegni che i firmatari hanno sottoscritto.
Appare di sicuro interesse il tema delle compensazioni geotermiche che arrivano ai territori ospitanti impianti di produzione geotermoelettrica.
Esse sono dovute per ricompensare almeno in parte l’onere sostenuto dai territori.
Tale principio, già sancito dalla normativa nazionale, è stato poi rafforzato dalla Regione Toscana che, proprio con l’Accordo Generale sulla geotermia, ha ottenuto che le risorse dovute fossero aumentate, che si stabilisse un principio di redistribuzione in chiave solidaristica e che, infine, si affiancassero una serie di condizioni volte al miglioramento delle ricadute sotto il profilo degli impatti socio-economico-ambientali.
 Grazie all’Accordo Generale sulla Geotermia e dei successivi Accordi attuativi si è riusciti, nell’ambito di uno strumento di tipo volontario, a concordare una serie di impegni da parte del soggetto industriale sia economici (il fondo geotermico, investimenti in ricerca e sviluppo per le migliori tecnologie ambientali applicabili), sia sociali (con particolare attenzione alla tutela occupazionale in termini quantitativi –numero di addetti- e qualitativi –formazione degli addetti, sicurezza e condivisione di percorsi consolidamento delle relazioni industriali lungo la filiera produttiva) e, soprattutto, ambientali (con la chiusura degli impianti più obsoleti e inquinanti, la costruzione di termodotti a servizio di aree artigianali, adozione dei filtri AMIS, certificazione EMAS, impegno a collaborare con ARPAT per la fornitura di dati utili ai fini dei monitoraggi delle emissioni).
Grazie all’Accordo Generale sulla Geotermia e dei successivi Accordi attuativi si è riusciti, nell’ambito di uno strumento di tipo volontario, a concordare una serie di impegni da parte del soggetto industriale sia economici (il fondo geotermico, investimenti in ricerca e sviluppo per le migliori tecnologie ambientali applicabili), sia sociali (con particolare attenzione alla tutela occupazionale in termini quantitativi –numero di addetti- e qualitativi –formazione degli addetti, sicurezza e condivisione di percorsi consolidamento delle relazioni industriali lungo la filiera produttiva) e, soprattutto, ambientali (con la chiusura degli impianti più obsoleti e inquinanti, la costruzione di termodotti a servizio di aree artigianali, adozione dei filtri AMIS, certificazione EMAS, impegno a collaborare con ARPAT per la fornitura di dati utili ai fini dei monitoraggi delle emissioni). Il combinato di tutti questi impegni, sotto la supervisione del governo regionale e grazie all’assistenza tecnica di CoSviG, ha consentito che negli ultimi anni si potesse parlare di un modello di sviluppo delle aree geotermiche in Toscana.
Modello in cui le parti svolgono il proprio ruolo a tutela degli interessi rappresentati (le popolazioni, le amministrazioni locali, il governo regionale, i soggetti industriali), in un’ottica collaborativa per il perseguimento del bene pubblico, senza che l’esasperazione delle contrapposizioni determini esiti svantaggiosi.
Nei territori geotermici toscani la combinazione di volontà politica, consapevolezza degli amministratori e collaborazione dei soggetti privati ha consentito l’avvio di un percorso di sperimentazione che resiste nonostante le mutate condizioni congiunturali complessive.
Sergio Chiacchella
Direttore Generale CoSviG Scrl
Originariamente pubblicato su QualEnergia Anno XVI n.2 Aprile/Maggio 2018